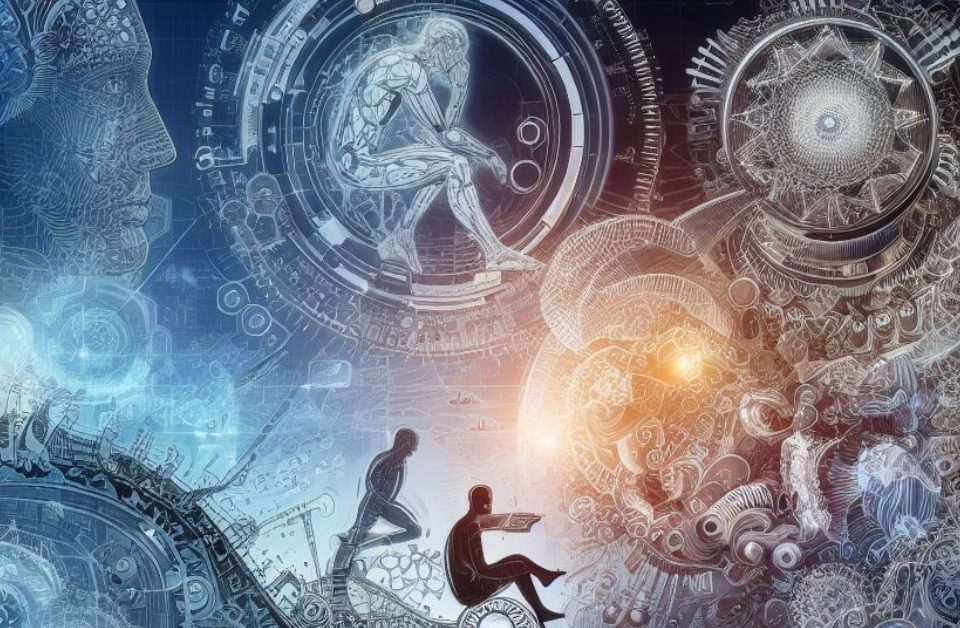Il prof. Muscolo e la gamificazione dell’apprendimento

Tutto pronto per la Settimana delle Culture Digitali “Antonio Ruberti” (9-15 maggio 2022)
23/04/2022
Webinar “Dal TgCulther alle WebTV culturali scolastiche” – 12 maggio
10/05/2022Il prof. Muscolo e la gamificazione dell’apprendimento

Image licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
a cura di Piero Chiabra, diGenova OdV
Chi abbia letto quel bellissimo e divertente libro che è “Il giornalino di Gian Burrasca”, di Vamba, ha ben presente chi sia il prof. Muscolo. Questo personaggio, siamo nei primi anni del XX secolo, è l’insegnante di greco del giovane Giannino Stoppani, il protagonista del romanzo, ed è stato soprannominato dai suoi alunni (il nome originale è ignoto) “prof. Muscolo” perché, durante le sue lezioni, pretende non solo la più totale attenzione e il più completo silenzio, ma anche l’assoluta immobilità da parte di tutti gli studenti, interrompendo ogni tanto il discorso per urlare loro “Tutti fermi! Tutti zitti! Guai se vi vedo muovere un muscolo del viso!”.
La figura del prof. Muscolo è ovviamente esagerata per ottenere un effetto comico, però, come molte altre cose in quel libro, è altamente rappresentativa di un modo di essere comune nella nostra tradizione, e, in particolare, nella nostra tradizionale cultura scolastica: una trasmissione rigida del sapere, che evita la discussione, impartita da una auctoritas incontestabile, verso un auditorio completamente passivo, che deve solo acquisire (meglio se a memoria) le nozioni impartite, senza neanche non solo discuterle (per carità!), ma neanche avere occasioni di approfondimento, di interiorizzazione, di elaborazione personale.
Questo modello, che è stato centrale per molto tempo nella scuola italiana, non è stato, duole dirlo, ancora superato neanche oggi.
E questo è un grosso problema.
Se quel modello infatti, poteva essere nonostante tutto valido per impartire insegnamenti in un mondo statico, in cui la cultura era consolidata, immutabile (o mutevole molto lentamente), e strutturata su modelli idealistico-umanistici considerati, a torto o a ragione, eterni, esso viene completamente a risultare inefficace e obsoleto quando si tratti di fornire elementi di cultura, relativamente a qualunque materia, in un mondo che si evolve ad un ritmo sfrenato, in una società in perenne cambiamento, pervasa da una cultura soprattutto scientifica in rapidissimo progresso, e nel quale la vita, in tutti i suoi aspetti, anche quelli di ogni giorno, è dominata da tecnologie sempre più complesse e più pervasive, ed esse stesse in tumultuosa evoluzione: tipologie di culture scientifico-tecnologiche nelle quali oltretutto, sempre più spesso, i (pochi) professori Muscolo superstiti devono confessare la loro incompetenza.
Il sistema deve cambiare. E il cambiamento è iniziato.
Partendo dall’insegnamento di Maria Montessori, la prima a infrangere questi schemi tradizionali, sono stati sviluppati nel mondo in questi ultimi anni numerosi tentativi per giungere ad un nuovo concetto di scuola altamente innovativo, in cui gli alunni “amino imparare”, perché sono indotti ad apprendere in maniera naturale, spontanea e non costrittiva. La parola d’ordine, in questo caso, è “gamification”: riutilizzare per l’insegnamento, anche di materie complesse, quella modalità di apprendimento che è la più naturale per l’essere umano, e che lo ha accompagnato sin da quando si è evoluto dallo stato animale: il gioco. Ovviamente, la cosa non è così banale, una cosa è una scuola, un’altra è un parco giochi.
Bisogna strutturare modalità di insegnamento che adottino il gioco come strumento di apprendimento in modo tale da trasmettere insiemi di conoscenza coordinati e coerenti, in modo da definire un percorso formativo che porti alla padronanza e alla corretta gestione dei contenuti forniti (se lo si può fare per un videogioco, strutturato su vari livelli gerarchici interconnessi…); al tempo stesso è utile sfruttare le modalità avanzate permesse dalla tecnologia per strutturare giochi i quali, oltre a fornire nozioni e contenuti tecnici e culturali siano in grado anche di provvedere occasioni di sviluppo dei cosiddetti “soft skill”, vale a dire di quelle capacità attitudinali e caratteriali, quali l’ abilità di comunicazione, la capacità di svolgere lavoro in gruppo, l’approccio razionale e strutturato alla soluzione dei problemi, la razionalizzazione e l’efficientamento dello stesso modo di imparare, etc., che sono alla base non solo delle possibilità di affermazione e di successo professionale, ma anche delle capacità di rapportarsi con gli altri, e sviluppare comportamenti tali da permettere agli studenti di diventare buoni cittadini, di aprire gli occhi sul mondo, e di sviluppare autonomamente interessi culturali indipendenti.
Ci sono, un po’ in tutto il mondo, svariati tentativi di questo tipo, dalla Ad Astra Nova High School di Joshua Dahn alla piattaforma Synthesis, alla piattaforma Duolingo per l’insegnamento delle lingue, ai vari tentativi europei e alla sempre maggiore diffusione di software didattici tendenti a questo scopo. E anche in Italia, seppure episodici e limitati, vi sono alcuni tentativi in corso.
E uno di questi tentativi è portato avanti da diGenova – Urban Digital Transformation, con un “package” di supporto agli istituti scolastici per la fruizione di contenuti complementari al tradizionale corso di studi, e funzionali alla diffusione della conoscenza delle tecnologie digitali e allo sviluppo delle soft skill.
Questo package, che può essere configurato e specializzato sui requisiti e le esigenze dei singoli istituti scolastici, comprende una serie di moduli, ciascuno dei quali volto a trasferire agli studenti conoscenze relative ad un aspetto delle tecnologie digitali, e/o a implementare una esperienza tale da favorire lo sviluppo di soft skill quali il lavoro di gruppo, le capacità organizzative e auto organizzative, il ragionamento per obiettivi, etc.
Il package, che viene svolto nell’ambito delle attività di PCTO, è per l’appunto imperniato sul principio di base di ottenere l’apprendimento attraverso il coinvolgimento degli studenti in attività di laboratorio a marcato carattere ludico, in esercitazioni che ne attraggano l’interesse e ne stimolino il senso dell’”apprendimento giocoso”, e dello spirito di cooperazione: in questi moduli, quindi, si trasmettono due differenti varietà di insegnamenti: quello inerente al contenuto diretto, vale a dire all’argomento che il modulo tratta, e quello relativo all’insegnamento indiretto, che riguarda le modalità di fruizione del modulo e di partecipazione attiva alle attività previste, con la conseguente maturazione di capacità di “soft skill”, di importanza, dal punto di vista formativo, pari se non superiori a quelle della “materia di insegnamento” ufficiale.
Ad oggi, il package è composto dai seguenti moduli:
- Un “contest” a quiz per la valutazione delle competenze digitali tra gli studenti, implementato tramite il software KAHOOT, e articolato in quattro diverse sezioni: alfabetizzazione digitale, comunicazione, creazione di contenuti digitali, sicurezza e benessere digitale, con gara e premiazioni (virtuali) per i vincitori.
- Un modulo di insegnamento di elementi di Project Management, in cui, dopo una “lezione frontale” introduttiva, gli studenti si suddividono in gruppi e devono tracciare un piano di progetto per un obiettivo designato (nello specifico, lo svolgimento di un saggio teatrale di fine anno), rispettando obiettivi, budget e qualità del prodotto, definendo i task, le attività e le milestone, sequenziandole e sincronizzandole correttamente, e operando scelte in merito alla priorità e alla fattibilità degli obiettivi da ottenere. I piani di progetto così prodotti vengono poi esaminati e valutati da un esperto.
- Un modulo per familiarizzare gli studenti con l’analisi dei big data; anche qui, il modulo è strutturato su una lezione “frontale” introduttiva, seguita dall’utilizzo di tool di data mining per la analisi e la strutturazione di dati, nella fattispecie TABLEAU ONLINE, con cui effettuare l’analisi approfondita, l’interpretazione e la presentazione dei dati relativi ad uno specifico ambiente, nella fattispecie attuale una base dati riguardante gli atleti partecipanti alle Olimpiadi moderne. Ciò da parte di vari gruppi di lavoro indipendenti, i quali presentano poi le loro elaborazioni e conclusioni, che vengono commentate e validate da esperti.
- Una gara di sviluppo di “giochi”, sulla falsariga del gioco dell’oca, tramite l’utilizzo del tool SmartOCA di Edutainment Formula (https://www.edutainmentformula.com/ ), volti alla familiarizzazione di diversi contenuti e problematiche culturali. Il contest è stato, anche qui, portato avanti da gruppi di lavoro in competizione tra loro, i quali hanno generato quattro giochi diversi: uno sugli animali in pericolo nel mondo, uno sui miti greci, uno sugli sport e uno su un tour geografico del mondo. Gli studenti sono stati responsabili sia dell’individuazione dei contenuti, sia dello sviluppo della grafica (in alcuni casi, come quello dei miti greci, con risultati molto pregevoli) che della generazione del meccanismo di gioco, utilizzando il tool di configurazione e le facilities di SmartOCA. I risultati sono stati oltremodo pregevoli ed originali. E divertenti.
- A NERD Dogma: Un “gioco a chiave”, sviluppato dal DIBRIS, dell’Università di Genova (https://dibris.unige.it/), basato sul classico principio della “fuga della stanza chiusa”(escape room), con l’obbiettivo di familiarizzare gli studenti con le problematiche relative alla sicurezza dei dati, alla crittografia, e alla protezione dei dati e dei contenuti digitali i vari gruppi di lavoro devono “fuggire” da una stanza sigillata e, per sbloccare le varie “serrature” che gli impediscono l’uscita, devono fornire degli opportuni codici di sblocco, i quali devono essere ritrovati tramite una complessa procedura di ricerca, che comprende calcoli matematici, ricerca di informazioni su Internet, risoluzione di rompicapo, , sulla base di una falsariga precedentemente preordinata dai formatori.
A questi moduli propriamente, detti, si aggiungono alcune “lezioni frontali” destinate a informare gli studenti su problematiche complesse e di difficile trattazione con strumenti ludici, quali i pericoli e le modalità corrette di approccio alla rete (lezioni svolte in collaborazione con il CICAP, il Comitato Italiano di Controllo sulle Pseudoscienze (https://www.cicap.org), benemerita organizzazione dedita da decenni a combattere contro le fake news e le superstizioni, in rete e non solo), e relativamente alle problematiche di privacy e sicurezza della navigazione su Internet, e delle precauzioni da adottare (queste ultime tenute da specialisti industriali del settore).
Questo package, in due differenti configurazioni, è stato implementato in due importanti istituti scolastici genovesi: il Liceo Classico D’Oria e il Liceo Classico Colombo, con risultati molto positivi, sia a detta dei docenti che degli studenti, i quali, lo abbiamo potuto constatare di persona, hanno subito sposato il nuovo metodo di insegnamento e contenuti con interesse, a tratti con entusiasmo, spesso andando anche al di là di quanto era stato loro richiesto come prestazioni, esprimendo anche il desiderio e l’interesse di approfondire i contenuti presentati, magari anche autonomamente.
Project management. Data mining e Data management. Creazione di contenuti digitali. Elementi di crittografia e sicurezza on line. Lotta alle fake news e utilizzo accorto e responsabile del web. E, trasversalmente, sviluppo dei soft skill tramite il lavoro di gruppo, il ragionamento per obiettivi, la gestione di progetti.
Si tratta di un insieme integrato di elementi formativi che seppur forniti con evidenti limiti di spazio, tempo e completezza, possono, se non altro, risvegliare negli studenti delle curiosità, e stimolare la loro attenzione e il loro interesse a sviluppare un insieme organico di competenze e skill in grado di assicurare sia la formazione di una valida professionalità, utile orizzontalmente in tutti i settori lavorativi, sia stimolare la creazione di una mentalità, di un approccio alla risoluzione dei problemi che induca ad una maturazione complessiva della personalità, e alla scelta razionale ed efficace delle proprie stesse opzioni di vita.
Non è poco. Ci sono tante, tante cose nuove da imparare.
E che i muscoli del viso si muovano pure, magari allargandosi in un sorriso.
APPROFONDIMENTI